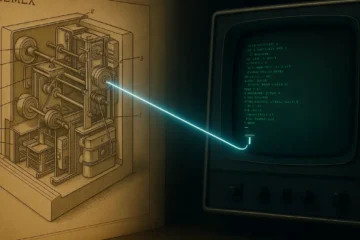L’entrata in vigore della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 ha segnato uno spartiacque storico nel diritto sanitario e nella bioetica italiana. Prima di questa norma, il rapporto tra medico e assistito si muoveva in una zona grigia, spesso dominata da un paternalismo medico che lasciava poco spazio alla volontà del malato, specialmente nelle fasi critiche del fine vita.
La normativa non si limita a burocratizzare delle procedure, ma ridefinisce l’intera architettura della relazione di cura e di fiducia. Non siamo più di fronte a un paziente che “subisce” la medicina, ma a una persona che esercita il proprio diritto costituzionale all’autodeterminazione. Analizziamo nel dettaglio quali sono i pilastri che sostengono questa riforma e come impattano concretamente sulla vita dei cittadini e sul lavoro dei sanitari.
Il consenso informato come fondamento della cura
La prima e più rilevante innovazione risiede nella codifica del consenso informato non più come semplice atto burocratico (il classico modulo da firmare frettolosamente), ma come processo continuo. L’articolo 1 stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata.
La legge sancisce un principio culturale prima ancora che giuridico: il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. Questo passaggio è cruciale. Significa che spiegare, ascoltare e assicurarsi che il paziente abbia compreso diagnosi, prognosi, benefici e rischi non è un’attività accessoria, ma parte integrante della prestazione sanitaria.
Il diritto all’autodeterminazione si spinge fino alla possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali.
“Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso.” (Art. 1, comma 5).
Nutrizione e idratazione artificiali sono terapie
Per anni la giurisprudenza e la bioetica si sono divise sulla natura dell’alimentazione e dell’idratazione fornite tramite dispositivi medici. Erano da considerarsi semplici sostegni vitali di base o vere e proprie terapie? La Legge 219/2017 ha risolto il dubbio in modo netto: nutrizione e idratazione artificiali sono trattamenti sanitari a tutti gli effetti, in quanto richiedono la somministrazione su prescrizione medica e l’utilizzo di dispositivi tecnici.
Questa classificazione ha una conseguenza immediata: essendo trattamenti sanitari, possono essere rifiutati dal paziente o interrotti, qualora il soggetto li ritenga non più tollerabili o non dignitosi per la propria condizione. Questo punto è stato centrale per superare le incertezze che avevano caratterizzato casi storici come quello di Eluana Englaro.
Il divieto di ostinazione irragionevole
Un altro pilastro della normativa riguarda il delicato equilibrio tra cura e accanimento. La legge introduce il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure. Nei casi di pazienti con prognosi infausta a breve termine o in condizione di morte imminente, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati.
Qui la legge introduce e legittima la sedazione palliativa profonda continua. Se il paziente soffre di sintomi refrattari (non gestibili con altre terapie) e si trova in prossimità della morte, può richiedere di essere sedato in modo profondo e continuo fino al decesso, per non percepire dolore o angoscia. È fondamentale distinguere questa pratica dall’eutanasia: l’obiettivo della sedazione non è abbreviare la vita, ma eliminare la sofferenza in una vita che sta naturalmente finendo.
Le DAT: il Biotestamento diventa realtà
Forse l’aspetto più mediatico della legge è l’introduzione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), comunemente note come biotestamento.
Le DAT permettono a ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.
Come si redigono le DAT
La procedura è stata semplificata per favorire l’accesso a questo diritto:
- Atto pubblico notarile.
- Scrittura privata autenticata.
- Scrittura privata consegnata personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del proprio comune di residenza (senza costi).
- Presso le strutture sanitarie (ove previsto dalle regioni).
Un elemento chiave è la nomina del fiduciario, una persona di fiducia chiamata a rappresentare il paziente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie qualora il paziente non sia più in grado di esprimersi.
Nonostante l’importanza di questo strumento, i dati mostrano un’adesione ancora lenta. Secondo l’Associazione Luca Coscioni e i report del Ministero della Salute, al 2024 le DAT depositate nella Banca dati nazionale sono circa 315.000, una percentuale minima (sotto l’1%) rispetto alla popolazione adulta italiana. Questo evidenzia una carenza informativa istituzionale ancora da colmare.
La Pianificazione Condivisa delle Cure
Spesso confusa con le DAT, la Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC) è una delle innovazioni più pragmatiche della legge, descritta all’articolo 5. A differenza delle DAT, che sono redatte da una persona sana (o comunque capace) per un futuro ipotetico, la PCC si rivolge a chi è già affetto da una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta.
In questo scenario, medico e paziente pianificano insieme il percorso terapeutico futuro, decidendo “ora per allora” come gestire le eventuali complicanze o la fase terminale della malattia. Una volta sottoscritta, la pianificazione è vincolante per i medici che la riceveranno, anche se il paziente dovesse perdere coscienza.
Responsabilità del medico ed esenzione
La legge tutela anche il professionista sanitario. L’articolo 1, comma 6, specifica che il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale.
Tuttavia, il medico non è un mero esecutore. Le DAT possono essere disattese (in tutto o in parte) dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora:
- Appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente.
- Siano sopraggiunte nuove terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione delle DAT, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Conclusioni operative
La Legge 219/2017 ha spostato l’asse decisionale, restituendo al malato la dignità della scelta. Non si tratta di promuovere la morte, ma di rispettare la vita e i valori della persona fino all’ultimo istante. Per i professionisti del settore e per i cittadini, conoscere questi strumenti non è solo un dovere civico, ma una necessità per garantire che le proprie volontà siano rispettate quando non si avrà più voce per esprimerle.
Per approfondire il testo completo della norma, è possibile consultare la Gazzetta Ufficiale – Legge 219/2017 o la sezione dedicata sul portale del Ministero della Salute.
Domande Frequenti (FAQ)
Posso cambiare idea dopo aver depositato le DAT? Assolutamente sì. Le Disposizioni Anticipate di Trattamento sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Se l’emergenza non consente la revoca scritta (ad esempio in situazioni di urgenza medica), la volontà può essere espressa verbalmente o tramite videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.
Il medico è obbligato a seguire le mie volontà anche se portano alla morte? Sì, il medico ha il dovere di rispettare la volontà del paziente di rifiutare o interrompere i trattamenti, incluse nutrizione e idratazione artificiali. La legge esonera espressamente il medico da responsabilità civile e penale quando agisce nel rispetto delle volontà espresse consapevolmente dal paziente.
Che differenza c’è tra DAT e suicidio assistito? Le DAT riguardano il rifiuto di terapie (lasciando che la malattia faccia il suo corso naturale senza accanimento). Il suicidio assistito (regolato dalla sentenza Cappato/Antoniani della Corte Costituzionale, non direttamente dalla L. 219/2017) prevede un atto attivo per porre fine alla vita. Sono due istituti giuridici ed etici distinti.
È necessario il notaio per fare il biotestamento? No, non è obbligatorio. Sebbene l’atto pubblico notarile sia una via possibile, la legge permette di redigere le DAT tramite semplice scrittura privata da consegnare personalmente all’Ufficio di Stato Civile del proprio comune. Il servizio comunale è gratuito e garantisce l’inserimento nella Banca Dati Nazionale.